Non saprò mai cosa spinse mio padre a spararsi un colpo di pistola in quel bruciante tramonto di trent’anni fa, la sera prima della sua esecuzione all’Opera di Parigi del concerto n. 1 di Chopin.
Eppure la vera tragedia non al vissi allora. No. La mia sensazione, in quel momento, fu quella dell’impossibilità di comprendere ciò che era accaduto e di credere reale l’intera scena: come se quell’uomo dal capo riverso sulla tastiera bianca macchiata di sangue non fosse stato davvero mio padre ma un attore, mirabilmente calato nella parte che da un attimo all’altro dovesse rialzarsi per rassicurarci, col tipico sorriso di chi si rivolge al pubblico, che era stato bello e coinvolgente, ma ora tutto era finito e la realtà tornava a vestire i suoi panni quotidiani.
Purtroppo, però, non si trattava di una finzione e l’espressione più indispettita che disperata di mia madre, lo squarcio all’altezza della manica che un movimento forse troppo brusco aveva provocato nella giacca di mio padre, le pareti bianche di quella lussuosa villa al centro di Parigi, il terrore che qualcuno potesse avvicinarmi a quel corpo inanimato, fecero di quella scena un nodo di sensazioni contrastanti che per anni sono stato incapace di sciogliere.
Ciò che avvenne subito dopo, l’ho rimosso: ricordo solo vagamente valigie preparate in tutta fretta, traboccanti di abiti eleganti ormai ridotti a stracci di seta, una bottiglia di profumo in frantumi sul pavimento, la sua essenza soffocante che si diffondeva per le stanze deserte e, ancora una volta, il volto serio, ma non addolorato, di mia madre.
Certo, la memoria ha strani meccanismi: assimila qualsiasi violenza, anestetizza qualsiasi dolore, lasciando solo un breve malessere che accompagna le ore, i mesi, gli anni e poi diventa la vita stessa, tanto che, alla fine, non si percepisce più; come il ticchettio monotono che discende dalla parete ove è appesa una vecchia pendola cui più nessuno dà la carica ma che scandisce un suo tempo, misterioso e lontano.
Tornammo in Italia, dove mia madre riprese a impartire lezioni di canto e un giorno, contemplando la mia immagine allo specchio, decise che la mia figura troppo pingue e i chili in eccesso mi avrebbero senz’altro impedito di intraprendere la carriera artistica (giacché era già deciso che sarei diventato un pianista come mio padre) e che, per lo stesso motivo, era necessario correre al più presto ai ripari.
Il “riparo” significò per me cinque anni di clausura in un istituto per obesi, dove avrebbero dovuto insegnarmi un’alimentazione corretta e dove imparai a distinguere me stesso dagli altri solo sulla base dei chili in più o in meno che caratterizzavano i nostri corpi. Ma si sa, non c’è prigione all’interno della quale un individuo, anche il più misero, non sappia ritagliarsi un angolo di libertà e procurarsi una boccata di ossigeno per ricomporre quell’armonia che la sua esistenza brutalmente gli nega, e tutto ciò io lo trovai nello strumento del violino che appresi ad amare proprio in quel collegio, sempre per fuggire dal mio presente così come dall’incubo del mio passato.
Mi chiedo spesso cosa sarebbe stata la mia vita senza la musica; potrei dire, parafrasando un antico e grande filosofo, che solo suonando riesco ad attingere l’essenza di quella realtà che dalla maggior parte degli uomini è vissuta come in sogno, ma la verità è molto più semplice: suonare significa afferrarmi alle radici, sentirmi “fondato” in qualche luogo, camminare lungo una corda tesa sulla quale si distribuisce l’equilibrio di tutta la mia esistenza.
Certo, trascorsa l’adolescenza in quel famigerato istituto svizzero, fu inevitabile, all’inizio della mia giovinezza, misurarmi col pianoforte, giacché mia madre, la cui vocazione irresistibile rimaneva pur sempre quella di pianificare la vita altrui, aveva già deciso per me un futuro brillante come quello che mio padre, per misteriose ragioni, aveva voluto troncare.
Ma dovette ben presto arrendersi: il pianoforte era la mia bestia nera e tale sarebbe rimasto per sempre. Ogni volta che tentavo di eseguire qualcosa, il tremito delle mie dita era tale che a malapena riuscivo a sfiorare i tasti giusti e questo perché il suono armonioso associato a ciascuno di essi si trasformava, alle mie orecchie, nell’eco spaventoso di un colpo di pistola, quello stesso che, tanti anni prima, aveva messo fine alla vita di mio padre.
Bisognerebbe riconciliarsi col proprio passato: esso, un tempo, è stato presente ed ha rappresentato il nostro compito, il nodo da sciogliere, l’ostacolo da superare; ma queste sono cose che diciamo agli altri, il sentiero che indichiamo loro quando smarriti ci chiedono la via. Noi, invece, ce ne stiamo a letto a fumare, a macerarci, e la nostra vita se ne va in fumo, proprio come quelle sigarette.
Quando fu evidente che il mio trauma infantile mi avrebbe impedito per sempre di realizzare le ambizioni materne, tornai a quella che era, per me, la voce del presente: il violino, il cui suono è bellezza pura. Non per costruire la brillante carriera che altri sognavano al posto mio, ma solo per trovare me stesso e, chissà, forse la pace dei ricordi.
Così sono tornato a Parigi, ho salito di nuovo le scale del Sacro Cuore e ho contemplato dall’alto la città bella come una regina: ho ammirato le sue statue abbaglianti di gloria, le sue chiese antiche come il mondo; ho sostato sotto l’arco di trionfo e ho imparato a memoria i suoi eroi scolpiti nella pietra; ho pregato alla luce sommessa delle vetrate sante di Notre Dame, mi son sentito nuovo e antico nello stesso tempo, ma comunque pronto.
Credo di aver avuto sempre un aspetto sotterraneo del mio carattere, come tutti del resto; quello dove scorre una corrente segreta che trasporta le immagini di estrema bellezza evocate dal nostro io quando, per pochi istanti, cessiamo di sorvegliarlo e soffocarlo con le cautele del buon senso.
Forse per questo ho subito amato la metropolitana di Parigi, quel gigantesco ventre sotterraneo dove l’inizio si ricongiunge con al fine, dove ci si perde e ci si ritrova, dove si vive come in un sogno oscuro, come messi in parentesi prima di essere “sbadigliati” alla luce del giorno e restituiti all’incanto della città.
Ho stabilito la mia dimora in quel mondo sotterraneo: per vivere suono il violino, suono musiche trasparenti come sogni o infuocate come danze di gitani al chiaro di luna, suono per viaggiatori distratti e nervosi che spesso fanno cadere nel mio piatto le loro monete di disprezzo o di pietà; sono un incantatore e loro i topi che prima o poi verranno trascinati dal mio suono.
Non m’importa del successo e delle sue chincaglierie, mi basta questo tramonto che incendia Parigi, qui, dall’alto di Montmatre, coi suoi quartieri da ex mercanti di schiavi e i suoi bazar di stoffe colorate, impregnanti dagli odori pesanti di una cucina a poco prezzo; qui, forse perché è di nuovo il tramonto, posso comprendere la morte di mio padre e il suo miraggio; qui posso abbeverarmi alla fonte che zampilla dal passato ed uscirne nuovo come un bimbo.
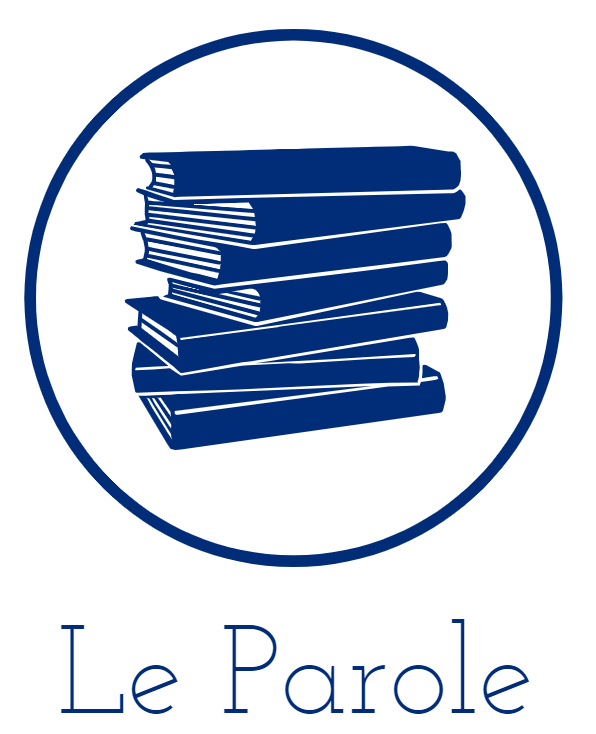
Che dire è un bellissimo racconto che tocca le corde dell intimità di ogni essere umano. basta fermarsi leggere lentamente e lasciarsi attraversare da ricordi ed emozioni